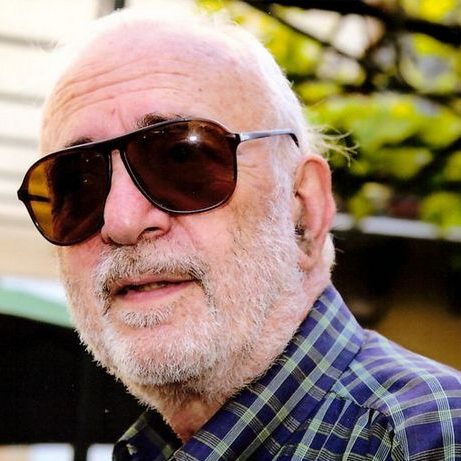Cefalù (Pa) – Da qualche giorno mi son trovato fra le mani, a lenire con la distrazione della lettura l’intensa estiva calura della campagna ove mi trovo a villeggiare, un libretto di 140 pagine circa licenziato alle stampe qualche anno fa, testé regalatomi dalla cordialità dell’autore, l’amico Francesco Dolce.
Un’autobiografia.
Mi sono sempre chiesto perché si scriva un’autobiografia.
La si scrive, a scopo terapeutico, per scaricarsi di un magma interiore vessante, doloroso, affliggente, indicibilmente sofferto o gioioso che sia, e poter visualizzare, a freddo, il materiale asportato onde riconsiderarlo e rivalutarlo meglio alla luce di un distacco temporale più o meno congruo, supportati da una maggiore obiettività acquisita seppure a prezzo di non indifferenti sacrifici e di ineludibili soddisfazioni?
E questo delineerebbe il lato patologico del dilemma.
Oppure la si scrive per un desiderio di visibilità, per fornire un rinnovato lustro alla propria personalità ostentando su una pubblica cartacea ribalta l’adamantina individuale valenza accreditata dal superamento di ostacoli, più o meno gravosi, che l’iter terreno non manca mai di frapporre dinanzi ai nostri incerti passi?
E qui ci troveremmo di fronte ad una ambizione incontenibile che spesso alligna nel nostro essere.
O la si scrive semplicemente per analizzare delle vicende, degli accadimenti, dei fatti, recenti o remoti che siano, da noi stessi determinati o meno, per stigmatizzare dei contenuti, per fissare dei ricordi, ad usum delphini per lo più, vicende, memorie, azioni, comportamenti in cui fortunosamente ci troviamo a gravitare, focalizzando l’approcciarsi del nostro “Io” ad essi e prendendo nota, a futura memoria, dei tortuosi ghirigori che l’esistenza, il caso o la prassi ci hanno posto innanzi?
A questo caso, che credo pertenga al nostro scrittore, meno problematico dei due precedenti ma forse più accreditabile, potremmo riconoscere una certa valenza, trattandosi, nelle intenzioni d’un neofita almeno, di un progetto di studio consapevolmente preordinato, inteso ad effettuare una ricerca dogmatica dalla quale possano scaturire esempi ed insegnamenti da seguire.
Sappiamo tutti che l’uomo, con la forza della riflessione, domina le sue titubanze, ma che spesso ne viene dominato; ed è, pertanto, giusto e doveroso, in tal frangente, che anziché annaspare nel pelago delle nebulose inconsistenze, dei dubbi e delle indecisioni, si adotti una strategìa difensiva, corroborativa, efficace col mettere in atto tutti quegli opportuni accorgimenti psicologici adatti all’uopo: uno di tali accorgimenti può benissimo estrinsecarsi privilegiando alla propria attenzione, come sostiene Fromm, il magma interiore estrapolato e studiarne la consistenza formulando delle deduzioni: un’autobiografia, quindi.
In fondo, se vogliamo proprio dirla tutta e cercare il pelo nell’uovo, come si dice, e grandangolarizzare l’universale punto di vista pianificando i concetti, anche la storia, a rifletterci bene, non è altro che la biografia di una nazione, la narrazione delle vicende di un popolo, le sue vicissitudini, il suo dibattersi alla ricerca affannosa d’un riscatto, di un rinnovamento sociale e culturale; pagine vergate, per altro, da un’anima eletta: lo storico.
Questi determina l’espressione concettuale che accomuna lo spirito alla materia, il senso interpretativo lato alla letterale veridicità dei fatti, l’essenza delle persone che furono alle idee ed ai programmi portati avanti o meno, fenomeni che si producono determinando effetti più o meno risolutivi ma di grande impatto sulla comune vita sociale.
Positivismo sperimentale o consociativismo di maniera?
Comunque, cercare il bandolo d’una aleatoria matassa, qual è quello di tentare di capire a fondo le motivazioni che possono spingere un uomo a fare qualcosa più che un’altra, è tutt’altro che facile; chiedersi il perché ed il percome, il modo, la ragione, la genesi d’un pensiero, d’una decisione, d’una memoria, d’un avvenimento recente o passato che sia, è naufragare nel buco nero dell’inconosciuto e dell’inconoscibile.
“Nulla si crea e nulla si distrugge” sentenzia il saggio, sgombrando il suo campo visivo da elementi fuorvianti che spendono la loro forza nell’allontanarlo dalla verità; una verità cosmica che è ben lungi dal rendersi palpabile, dal farsi conoscere. E’ come se l’universo istesso si prendesse gioco della nostra sete di sapere; come se, a nostro discapito, s’industriasse a tenerci costantemente immersi nell’informe lago dell’oscuro ignoto.
E’ meglio astenersi, quindi, dall’imbarcarsi in una ricerca conoscitiva, razionale, equilibrata ed analitica, non solo nello sceverare le motivazioni di una scrittura autobiografica che qui forma oggetto di esame ma anche in innumerevoli altre direzioni; ricerca, dicevo, che, dati i presupposti di difficoltà d’indagine, indiscutibilmente ci condurrebbe in un labirinto di ipotesi, di tesi, di falsi convincimenti, se non addirittura in un labirintico pozzo senza fondo.
Nietzsche includerebbe nel suo “nus” il coacervo dei tentativi umani spesi per cercare di sondare l’ignoto.
Molteplici sono, dunque, le motivazioni che inducono un individuo a spalancare la finestra del proprio animo ed a mettere a nudo i propri più intimi sentimenti, dipanando le più riposte pieghe del proprio sentire, qualificando le proprie più profonde emozioni, positive o negative che siano, i propri più celati pensieri per un bisogno ancestrale, il più delle volte, di trovare una “spalla” su cui riversare le nebulose incertezze del proprio sentire e che possa comprendere le angosce, i timori, le sofferenze, le speranze, gli sperati raggiungimenti che ci assillano e che hanno costellato e costellano il nostro oneroso transito terreno.
Diciamolo pure: tutte le motivazioni qui addotte, informi incerti tentativi, trovano campo, luogo, senso, considerazione e fondatezza per riuscire a poter sondare un’anima.
Ma il gesto, il proposito, l’intendimento di Dolce, il carisma, nel comporre questo suo testo autobiografico non trova accoglimento nelle varie congetture superiormente espresse, se non, come larvatamente già accennato, nell’intento cosciente dichiarato ed eticamente apprezzabile di porre la sua complessa dimensione conoscitiva, la sua indiscutibile competenza in svariati settori al servizio di quanti ne volessero usufruire.
Un atto d’amore cristiano, dunque? D’altruismo, in un momento storico come l’attuale in cui s’innesta meglio l’aforisma “…homo homini lupus…”?
Indubbiamente si. Un civile atteggiamento di irreprensibile disponibilità verso gli altri, nella serena consapevolezza che su questa terra siamo tutti fratelli e dobbiamo darci scambievolmente una mano.
L’esasperato ottimismo professato da Dolce nella convinzione che “dopo ogni nuvola c’è sempre il sole” trae linfa dalla fiduciosa attesa nel divenire, dalla radicata certezza che non siamo soli nell’universo ma che c’è sempre un provvido immanente superiore disegno che non ci abbandona mai, ma che ci guida e ci sostiene.
Emerge un naturale karma nel testo dolciano; vi si intersecano spunti familiari, scolastici, sociali, professionali e politici. “Multum in parvo”, come nei manuali Hoepli di felice memoria che hanno accompagnato noi discenti nei nostri incerti passi mossi nel lontano periodo della scuola media.
Il testo in esame è, forse, più teologico che narrativo, più didascalico che di maniera. Vi si coglie il sentimento, un sentimento profondo, come elemento catalizzatore di tutte le umane dimensioni, di tutte le pulsioni creative, di tutti gli interpersonali rapporti.
E’ un catalogo forbito, un concentrato di pulsioni, un vademecum comportamentale, il suo, redatto con lungimiranti benefici intenti.
Vi si coglie un adombrato sotterraneo incitamento al ben fare, all’onesto agire.
E’ una esemplificazione di ogni sano auspicabile modus agendi.
In buona sostanza il testo di Dolce non è solo una autobiografia: è anche un’autobiografia.
Si parte da essa per raggiungere, anche inconsciamente, un personale stato di grazia.
Chissà, a volerla certosinamente catalogare: potrebbe la sua autobiografia rappresentare, dal lato morale, un’appendice al testo di Monsignor Giovanni Della Casa? O, al contrario, sarebbe l’opera di quest’ultimo a doversi considerarsi come il fanalino di coda di quella di Dolce?
Moltissimi in tutti i tempi hanno scritto di sé: artisti della regìa del calibro di Chaplin, Zeffirelli, Woody Allen, e poi Murakami e lo sportivo Kobe Bryant, Roberto Bolle, comici come Giorgio Panariello o politici ed attivisti come il sudafricano Nelson Mandela, a non voler scomodare anche Proust con la sua recherche o il Manzoni, il Nievo, il Foscolo e tant’altri che con le loro opere, tanto per citare alcuni grandi, hanno tenuto banco; tutti hanno sentito l’impellente bisogno di esternarsi, di trasmettere la propria intima esperienza quasi a voler servire da traccia, da monito, da indirizzo in una realtà in continuo e perenne divenire (…tutto scorre…), lasciando una scia luminosa di pensieri, di azioni, di comportamenti, gocce di perenne saggezza, attraverso il dissertare su vari argomenti specifici di estrazione personale la cui peculiarità dottrinale rappresenta una espressione culturale di indiscutibile valenza scientifica e pratica.
Questo è un campo letterario che amalgama la professionalità alla estrema sensibilità; è un campo in cui la fioritura delle menti ha determinato un tracciato di esperienze dissimili nella forma ma unitarie nella sostanza.
“Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole”, chiosa con sicumera Francesco Dolce, Ciccu per gli amici, mettendo a frontespizio della sua pubblica “confessione” autobiografica, specificatamente letteraria, licenziata alle stampe per le edizioni Arianna, questo augurale e lungimirante titolo consono alla sua specchiata moralità, al suo adamantino carattere, al suo indefettibile credo, alla sua riconosciuta limpida etica, al suo “pabulum animi”, al suo ben evidente ottimismo, con la serena coscienza dell’uomo probo che ha votato la sua esistenza, un’esistenza la cui dirittura morale è più che attestata, a rendersi partecipe di una contemporanea problematica civile ed umana, ad immergersi in essa ed a tentare di favorirla al meglio scendendo in campo in prima persona.
Opera, la sua, supportata dalle personali sofferte esperienze che lo hanno sempre catarticamente convogliato, come si è accennato sopra, verso una disponibilità protettiva e di ausilio verso gli altri.
Il testo, di facile lettura, dagli accenti a tratti toccanti e sempre coinvolgenti, propone un excursus segnato dal pathos, civilmente sofferto, lacerato dall’immarcescibile ricordo dei genitori e del proprio figlio, Mario, venuto prematuramente a mancare, ma vissuto con abnegazione e fermezza da una natura eminentemente reattiva che pone nella fiducia e nella costante riflessione la sua primaria ragion d’essere.
Il condensato del libro, gli intenti, la genesi e quant’altro, elementi che costituiscono il clou della cifra narrativa del Nostro, già si rinvengono nelle dichiarazioni addotte nella introduzione che lo Stesso premette al lessico.
Egli afferma, infatti:
“…a guidarci non può essere l’orgoglio, la superbia, l’arroganza o la paura di cosa pensano gli altri, ma il senso del bene comune e l’umiltà di sapersi riconoscere nell’Universo che ci dà luce, speranza, vita…” (sic).
Concetti profondi e pregni d’un concentrato di fede e di oculata dirittura morale che solo l’esperienza, vissuta secondo i carismi sopra espressi, può dare.
In un altro passo chiosa ancora:
“…Ho attraversato il deserto, ho conosciuto la disperazione, ho dato fondo a tutte le mie riserve di speranza, ho vissuto la notte, anzi le notti infinite del buio e dell’incertezza…” (sic).
Frasi che adombrano una cocente angoscia che tempra un particolare percorso umano; angoscia tenuta a bada, tuttavia, da una ferrea volontà di ripresa grazie ad un attento controllo delle proprie più intense intime emozioni.
Il tutto corroborato dalla fede, ripeto, una fede profonda e costruttiva, unica speranza nel buio dell’immanente inconscio.
Nei cruciali momenti di disorientamento è facile perdersi d’animo per i tortuosi meandri della disperazione; ma come “l’urne dei forti il forte animo accendono indirizzandolo ad egregie cose” (la lungimiranza del Foscolo è insuperabile!), così il raggiunto dominio delle proprie pulsioni in un animo temprato mitiga i momenti più “neri” della propria esistenza; momenti in cui si vorrebbe abbandonare tutto e tutti e trascendere in imprecazioni contro una siffatta creazione apparentemente nemica dell’essere umano.
Certo, il dolore scaturente dalla perdita dell’amato figlio Mario ha funto da catalizzatore nello scrittore già provato dalla morte in guerra del padre Mariano.
In questo dualistico dramma si forgia il carattere di Ciccu, leader consapevole del suo tempo.
L’opera di Dolce, che nel suo iter terreno ha ricoperto anche prestigiose cariche politiche, sia a Polizzi patria d’origine che a Cefalù, si impone per l’energìa che da essa traspira; prende fiato man mano che le vicende narrate si dipanano; si irrobustisce allo spirare dell’afflato lirico da cui è permeata e per me resta una espressione umana significativa di un processo caratteriale altamente formativo.
S’impone anche per la cifra semplice e non cattedratica dello stile.
…Ho cercato di nascondere le mie cicatrici…ho vissuto assumendomi sempre la responsabilità della mia vita e delle mie esperienze…ho cercato sempre di ripartire, non per soddisfare una mia esigenza personale, ma per mettere la mia persona al servizio della società…” (sic).
In questa dimensione puramente altruistica, in queste sincere espressioni da cui si evince un totale spirituale “donarsi”, quasi un emblematico sacerdozio, in questa volontà primaria di essere utile e d’aiuto agli altri si compendia lo sforzo umano e letterario dell’autore che vive in simbiosi col suo tempo, con i suoi raggiungimenti e con tutti gli onnipresenti problemi che sono il corollario di ogni umana esistenza.
Giuseppe Maggiore